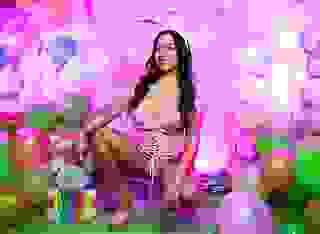Nota: puoi modificare la dimensione del carattere, il tipo di carattere e attivare la modalità oscura facendo clic sulla scheda dell'icona "A" nella finestra delle informazioni sulla storia.
Puoi tornare temporaneamente a un'esperienza Literotica® classica durante i nostri beta test pubblici in corso. Si prega di considerare di lasciare un feedback sui problemi riscontrati o suggerire miglioramenti.
Clicca quiEfisio le parlava in dialetto nuorese, quello particolare delle terre di Fonni, intorno al Monte Spada, poco distante dalla 'Madonna dei Martiri' dove, la domenica dopo la Pentecoste, andava a guardare le ragazze. Raccontava della sua gente, dei genitori, dei fratelli e della sorella, ma soprattutto di Cecilia, che avrebbe sposato non appena tornato. E intanto, la teneva pulita e lucida, che lei, Norma, gliene era grata e si girava a guardarlo, a ringraziarlo con le orecchie che muoveva avanti e dietro, anche per dirgli la sua amicizia.
Don Tarcisio, invece, le batteva la grossa palma della mano sul collo e le diceva che quella era la più brutta cosa che Norma avrebbe potuto vedere: la guerra. Uomini che uccidevano altri uomini, spesso senza saperne la ragione, con obbedienza cieca, rispettosa e assoluta; per un nome, Patria, che era caro al loro semplice cuore ma che, troppo spesso, nascondeva gruppi d'interesse, di potere, di prepotenza. Gruppi che nel sangue degli altri, nei dolori, nei lutti, nelle distruzioni, preparavano altre speculazioni.
"Norma" -diceva Don Tarcisio- "tu queste cose le comprendi meglio degli altri, perché tu vedi e taci, mentre gli altri non vedono, non capiscono, ma parlano. Tu mi aiuti a portare una parola buona, un po' di conforto a questi poveri figli lontani dalle loro mamme, ai padri distanti dalle famiglie. E speriamo che il Signore dia loro la forza di sopportare pazientemente questo grandissimo sacrificio. Vedi quanti morti ci sono, quanti corpi straziati. E cosa posso dire loro? Cosa posso inventare per invitarli alla pazienza, alla sopportazione? Cosa posso rispondere ai loro perché? Come posso trattenere le lacrime quando mi guardano, morenti, come se volessero la spiegazione del loro immolarsi per qualcosa che non comprendono? Quando, sentendosi spegnere, cercano le sbiadite foto di volti che non riescono più a distinguere se non nel ricordo, che va sempre più appannandosi, nella nebbia della morte? Che il Signore li accolga nella sua misericordia infinita, che conceda la rassegnazione ai loro cari, che ridoni il senno a coloro che stanno crocifiggendo questi novelli Cristi."
Questa volta Don Tarcisio aveva preavvertito la sua visita.
Avrebbe celebrato la Messa di Pasqua nella vecchia casa semidistrutta, poco discosto dai camminamenti e dalle trincee, dove, su un pezzo di legno bruciacchiato, con carattere incerto e con tinta nerastra, era stato scritto presuntuosamente Comando.
L'Ufficio Comando era una tavola poggiata su due cassette vuote, con un'altra cassetta per poltrona, e un fumoso lume che si accendeva il meno possibile per non consumare il petrolio. In un angolo del tavolo improvvisato, alcune carte e un telefono da campo con i fili che uscivano da uno dei tanti buchi del muro otturati con sassi, stracci, pezzi di cartone. Un telo da tenda conduceva nell'alloggio del comandante. I soldati s'erano dati da fare per costruire una specie di branda: un telaio di legno, fatto alla meglio, vecchie cinture annodate, qualche sacco riempito di chissà cosa, e una coperta da campo che conferiva al tutto un tocco di civetteria.
La Messa di Pasqua sarebbe stata celebrata nello spiazzo davanti al Comando. Era stata trovata una pezza bianca e messa sul 'tavolo' del Comandante, che era stato portato sull'uscio della casupola. Quattro pietre, agli angoli, impedivano al vento di portarla via. Due lumini, dal triste aspetto cimiteriale, scovati tra le macerie di quell'edificio, facevano da candele.
Malgrado si fosse già a Pasqua, la primavera non accennava a presentarsi. Le alture circostanti erano ancora coperte di neve, la pioggia gelata non cessava di cadere, incessantemente, giorno e notte, allagando trincee e camminamenti, trasformando i viottoli in torrentelli, inzuppando tutto e tutti. Gli uomini giravano avvolti in coperte fradice d'acqua, qualcuno, più fortunato, aveva un telo impermeabile. Ora, però, quei teli formavano una malferma tettoia per riparare l'improvvisato altare.
Le nuvole rotolavano fumose lungo i fianchi del monte e nascondevano del tutto la valle, celando ogni movimento di truppa e salmerie, inducendo alla pigrizia, all'immobilità.
Don Tarcisio, Efisio e Norma, salivano lentamente, lungo la mulattiera che portava al crinale inciso dalle trincee che lo solcavano come brutte cicatrici, come sezioni di formicai allagati percorsi da ombre che tossivano, gente che cercava di scaldarsi con qualche goccia d'acqua tinta che chiamavano caffè. Ognuno aveva una coperta, a mo' di mantello, per ripararsi alla meglio. La strada era molto stretta, sdrucciolevole, con curve difficili anche per Norma che cercava di non scivolare sulle pietre bagnate. Nel silenzio, Tarcisio aveva lasciato che il mulo li precedesse. Norma guardava per terra, dinanzi a sé, scegliendo attentamente dove mettere gli zoccoli, sbirciando di quando in quando i due uomini che la seguivano.
"Efisio" -disse don Tarcisio- "recitiamo il Rosario." E cominciò la preghiera, rivolgendola alla Madre di Dio perché intercedesse per la pace.
Nella bisaccia portata da Norma aveva messo una copia dei 'Ragionamenti'. Era per Siro, un giovanottone che si atteggiava a scettico tirando in ballo la 'razionalità a ogni costo'. Tra lui e Siro era sorta una stretta amicizia che, ne era certo, sarebbe durata anche dopo il congedo. Don Tarcisio, però, non comprendeva la totale avversione di Siro per la confessione. Il giovane sosteneva, e ne sembrava convinto, che stava a lui, e solamente a lui, stabilire se avesse intenzionalmente infranto la legge di Dio, e, nel caso, se fosse pentito e se avesse l'intenzione di non ricadere più in quello che i preti definivano peccato. Secondo Tarcisio, era tutta colpa di poche e confuse idee instillategli da qualche professoruncolo contestatore.
Avrebbe voluto portare un libro anche a Stefano, ma non era riuscito a trovarne uno che gli sembrasse adatto. Stefano si mostrava un ottimo conoscitore della Sacra Scrittura, in ogni occasione sapeva citarne il passo adatto al momento, collegava l'Antico al Nuovo Testamento, ne illustrava il significato, l'insegnamento che conteneva. Doveva aver sofferto molto. Il desiderio di sapere, conoscere, indagare, analizzare, approfondire, scavare nel pensiero proprio e degli altri per rilevarne analogie e difformità, forse era alla base delle sue delusioni, e la causa di qualcosa di grave che gli era accaduto.
Il latino e il greco, così come aveva potuto apprenderli, lo lasciavano insoddisfatto, non gli consentivano di immergersi nell'infinita profondità dei grandi pensatori di Roma e di Grecia, comprenderne totalmente la loro religiosità, perché certamente era presente, e in ogni caso era intesa.
"La guerra come mezzo per conquistare la, libertà" -diceva Stefano- "é offesa all'intelligenza dell'uomo, é il disprezzo per il più grande dono che Dio ci ha fatto: crearci simili a lui. Dio, Signore dello Spirito, Signore della Vita, non può volere la morte dei suoi figli, simili a lui. All'uomo sono state date intelligenza e parola perché possa discernere il bene dal male, possa pensare, parlare, esprimere il suo pensiero, comprendere di poter convivere in pace anche con chi ha principi contrari ai suoi. L'immensità dello spazio é stata voluta dal Signore per dirci che c'é posto per tutti, senza bisogno di violenza. E se ognuno ritiene di avere un 'predica' da fare, ascoltalo o non ascoltarlo, ma lascialo parlare. Il pensiero di chi é stato incenerito dal rogo é ricordato più ancora di quello ignorato e lasciato disperdere nel vento."
Nelle rare celebrazioni della Messa, Stefano restava in ginocchio, per tutta la durata, col capo chino e profondamente assorto. Non s'accostava mai, però, alla Comunione. E a Tarcisio, che gli aveva affettuosamente il perché, aveva risposto solo con un sorriso.
Era un carattere triste, sorrideva poco, non rideva mai. Eseguiva gli ordini senza discuterli, senza commentarli neppure coi commilitoni. Tutto il suo dissenso era rinchiuso in un tipico scuotere del capo, sconsolatamente, pur avviandosi a fare ciò che gli era stato ordinato, come se dovesse espiare una colpa.
Siro era il tipico 'prodotto' della bassa pavese. Alle spalle una 'licenza liceale', più o meno meritata, e una famiglia tutta intenta a 'strappare' ancora qualche campo ai padroni, quasi non fossero padroni loro stessi e non avessero braccianti al loro servizio. Per staccarsi dalla terra, Siro s'era iscritto all'Università di Pavia e aveva superato anche qualche esame, senza infamia e senza lode, ma soprattutto senza entusiasmo. Lui era fatto per stare con gli amici, fare una buona mangiata, e concludere il tutto con qualche ragazza che avesse spirito d'iniziativa, perché lui le avventure galanti era più portato a raccontarle fantasiosamente che a viverle concretamente.
Ogni tanto andava a Milano, a 'respirare l'aria della vera civiltà' come amava ripetere. In effetti, a Milano gli piaceva soffermarsi presso i capannelli dove si parlava di politica. Se interveniva era per dire di essere perfettamente d'accordo. Sia che si affermasse il 'nero' sia che si inneggiasse al 'bianco'. Non voleva inimicarsi nessuno anche perché, secondo lui, non tutti gli Austriaci erano andati via da Milano. Infatti, qualcuno li temeva ancora come possibili occupanti, pronti a opprimere di nuovo, a sfruttare la ricchezza lombarda; altri ne ricordava storicamente la passata permanenza, esaltandone l'ordine, la disciplina, l'efficienza della burocrazia. Di conseguenza, la polizia austriaca era fatta di 'sbirri', di 'tutori dell'ordine'. E poi, vuoi mettere l'imponenza di Francesco Giuseppe con lo sgraziato personale di Vittorio Emanuele?
Comunque, i filoaustriaci erano una sparuta minoranza che doveva stare bene attenta a parlare, perché il clima delle 'cinque giornate' era entusiasmante per molti, specie se non conoscevano le schioppettate.
Siro s'era spesso trovato coinvolto, suo malgrado asseriva, in manifestazioni interventiste. Trento e Trieste erano i motivi principali per cui si doveva abbattere l'aquila a due teste. Troppo a lungo i fratelli di quelle città, italianissime, erano stati sotto il tallone austriaco.
'A morte Franz, viva Oberdan!', e grida del genere salivano dai lunghi cortei vocianti, dagli assembramenti in cui si sventolava il Tricolore che doveva essere portato ai confini naturali della penisola. Era stato perfino rispolverato il vecchio 'Viva VERDI', Viva Vittorio Emanuele Re D'Italia.
Nelle caserme s'ammassavano vestiario ed equipaggiamento, si affilavano le baionette dei vecchi '91, s'approntavano i carriaggi, si studiava il percorso delle tradotte. Intanto, pietose dame, col volto contrito ma coscienti della loro 'determinante partecipazione' allo sforzo bellico, arrotolavano le candide bende che avrebbero fasciato le carni dei nostri eroici combattenti, straziate dalla barbara mitraglia nemica. Così si esaltavano, si eccitavano.
Il dovere d'ogni Italiano, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta, dalla Sardegna alla Puglia, era di partecipare alla liberazione delle terre occupate dall'Austria. Si mitizzava la bellezza del volontariato, la spontaneità dei giovani, l'entusiasmo di studenti, operai e contadini uniti dallo stesso anelito di vittoria, anche se qualcuno non era ancora riuscito a trovare Trento e Trieste sulla carta geografica. Si cominciava a chiamare uomini alle armi, a requisire multi.
Siro fu raggiunto dalla cartolina precetto mentre giurava agli amici che lui non aveva ancora fatto domanda d'arruolamento volontario per tema di essere tacciato di spacconeria.
Norma era già in caserma, nelle salmerie someggiate, e quando fu raggiunta dalla mobilitazione si limitò a battere per terra lo zoccolo anteriore destro.
Stefano aveva rigirato tra le mani l'ordine di presentarsi al Distretto Militare, pena la dichiarazione di diserzione. Anche quella volta, non gli era facile stabilire quale fosse il suo dovere. Rispettare la legge dell'uomo che gli diceva di uccidere altri uomini, o la legge di Dio che gli insegnava l'amore per il prossimo? E' vero che la scrittura dice di dare a Cesare quello che é di Cesare, ma si riferisce alle tasse, non alla guerra, e Cesare é il padrone della moneta che porta la sua effigie, non della vita. Anche le tasse, però, sono utilizzate per la guerra, moloch insaziabile, divoratrice d'uomini e distruttrice di beni, aperta ribellione alla volontà del Padre, anzi negazione del Padre, perché sono i promotori della pace ad essere "chiamati figli di Dio". Non era quello il tempo profetizzato da Isaia, quando con le spade si dovevano costruire aratri e falci con le lance.
Meglio non presentarsi, allora, disertare?
Ridda di pensieri che turbavano sempre più l'animo di Stefano, combattuto da opposte considerazioni. Anche la diserzione finiva con un'uccisione, la fucilazione. Era come suicidarsi sapendo di farlo. Ecco il primo effetto devastante della guerra: riproporre l'eterno dilemma del bene e del male, ma senza indicare quale sia il bene.
Prese poche cose, qualche libro, e si presentò al Distretto. Consegnò subito la domanda con la quale, esponendo il suo problema di coscienza, chiedeva di essere assegnato a compiti che, comunque, avessero potuto essere di qualche aiuto ai sofferenti. Il sergente, letto il foglio, guardò Stefano come qualcosa di disgustoso, poi gridò al caporale di metterlo alle latrine, così sarebbe stato d'aiuto ai cacanti.
Efisio aveva capito solo che doveva fare il soldato. Prese un pezzo di formaggio e un pane, salutò tutti e andò dai Carabinieri. Sulla nave che lo portava in continente c'erano tanti altri giovani, come lui, che vedevano il mare per la prima volta. Intorno ad un ragazzotto, tarchiato e forte come un torello, s'erano raccolte alcune reclute che ascoltavano, incantati, la fantasiosa descrizione che faceva delle donne del continente. Lui lo aveva saputo da un marinaio che aveva conosciuto donne in tutto il mondo. E qui seguivano le più incredibili 'varianti' anatomiche. Efisio pensò che Gavino lo aveva fregato quando s'era fatto dare mezza pezza di formaggio per fargli vedere la sbiadita fotografia dell'araba nuda, portata da Tripoli dov'era stato per quasi due anni. Quella Tripolina, salvo particolari insignificanti, era fatta tale e quale alle sorelle e alla donna che aveva incontrato al porto di Cagliari, prima della partenza. Solo che la donna del porto era quasi il doppio dell'arabetta, e aveva un sacco di pelo tra le gambe..
Comunque, si riprometteva di tornare sull'argomento.
* * *
Don Tarcisio era andato dal Vescovo, con la bella torta fatta dalla sorella, un cesto d'uova, quattro polli e una damigiana del miglior vino che aveva.
La sorella del Vescovo lo aveva ringraziato calorosamente, gli aveva detto che non doveva prendersi tanto disturbo, Don Tarcisio, sempre così gentile e generoso. Anche l'olio, portato la precedente volta, era stato veramente delicato e a Sua Eccellenza non faceva venire l'acido allo stomaco. Peccato che stava per finire. Tarcisio assicurò che avrebbe provveduto subito, grato e affezionato com'era a Sua Eccellenza.
Monsignor Remo Vassalli, Vescovo della Diocesi, l'attendeva nello studio appena rischiarato dalla luce che entrava dalla finestra ornata con pesanti cortine. Era un bell'uomo, alto, robusto, col volto ben rasato e sorridente, l'aria cordiale e accogliente. S'alzò e andò incontro a Don Tarcisio, impedendo che gli baciasse la mano e stringendolo in un caloroso abbraccio. Fraterno e affettuoso, non formale.
"Allora, Tarcisio, come va? Ho saputo che, come sempre, mi hai colmato di buone cose della campagna. Tu, però, a mia sorella non devi dare ascolto. Lei dice che io sono delicato di stomaco, e invece digerisco anche le pietre che, certo, sono molto più buone se condite col tuo olio. Olio che non é ancora finito."
E s'avviò verso il vecchio divano, tenendo Tarcisio sottobraccio.
Tarcisio si schernì, e con voce bassa e insicura disse: "Eccellenza..."
Ma l'altro l'interruppe ridendo. "Tarcì, ma che eccellenza e eccellenza, io mi chiamo Remo, Tarcì, ma che l'hai dimenticato?"
"Si, va be', grazie, ma... io, Parroco di campagna, e voi, scusate... tu sei il mio Vescovo. Come faccio... non ci riesco..."
"Tarcì, ma proprio perché sono il tuo Vescovo mi devi obbedire. Hai dimenticato che mi devi obbedienza, o dobbiamo stabilire chi comanda, come ai tempi del Seminario?"
Don Tarcisio, seduto accanto al Vescovo, teneva la testa bassa e cercava il modo di entrare in argomento.
"La Parrocchia va bene, é una grande soddisfazione poter essere al servizio di tanti, di quelli che si rivolgono a te con piena fiducia. E' bello far qualcosa per questa gente che, in fondo, é buona e onesta, che al massimo spettegola un po', guarda le donne e ci ridacchia sopra, e alla fine pascola nel proprio prato, si accontenta di quello che ha, ringraziando il Signore."
Il Vescovo assentiva col capo, ma guardava in modo interrogativo Don Tarcisio, aspettando di conoscere dove sarebbe andato a finire quel discorso, che sembrava proprio preparato.
"Solo che adesso" -proseguiva il prete- "ci sono tanti uomini che partono, giovani, ma anche più vecchi di me che non sono più un ragazzino, padri di famiglia, e nei campi a lavorare ci vanno i vecchi, le donne, i fanciulli. Don Marco, quel bravo sacerdote che mi é stato dato come aiuto, si fa in quattro. Chi lo chiama a destra, chi a sinistra. Lui ascolta tutti e ha parole buone per tutti, non solo, ma aiuta anche materialmente. Si, é veramente bravo Don Marco, un vero pastore amato dal suo gregge. E quando predica, la domenica, perché io lo faccio predicare alla Messa grande, lo ascoltano incantati."
"Tarcisio" -interruppe il Vescovo- "mi stai facendo morire, arriva al punto."
"L'ho detto. Don Marco può benissimo sostituirmi e prendere il mio posto, ed é certo che farebbe meglio di me. Così io andrò coi soldati, sarò vicino a loro come adesso, fratello ordinato, perché se le cose seguiteranno ad andare come al presente, e come temo, questi fratelli avranno sempre più bisogno di una parola che li conforti e li sostenga, li consoli nei momenti di smarrimento, hanno bisogno di essere assistiti se dovessero, malauguratamente, essere sul punto di abbandonare questa valle di lacrime, di odio, di violenza."
E piangeva, Tarcisio, senza neppure nascondere le lacrime che, copiose, gli rigavano il volto, cercando di parlare tra i singhiozzi:
"No, non é possibile che loro siano lì e io rimanga qui, non é per questo che mi sono fatto prete, non é per lasciarli proprio quando più devo stare vicino a loro..."
Il Vescovo gli aveva preso le mani, le stringeva, guardandolo fisso anche lui cogli occhi pieni di pianto, con un nodo che gli stringeva la gola. E quando parlò la sua voce non era quella di sempre: "Tarcisio, fratello mio, quanto mi mancherai..."
A tavola l'atmosfera non fu quella delle altre volte.
Non c'era mai stato formalismo, e in genere si parlava dei problemi della Diocesi e della Parrocchia. Oggi, invece, era tutto un chiedersi notizie della famiglia, un ricordare i tempi del Seminario, i compagni di studio, la meravigliosa attesa e l'infinita gioia per la prima Messa.
"Questa é la corona che m'ha regalato la mia povera mamma il giorno che mi sono separato da lei per entrare in Seminario," -disse il Vescovo- "e l'ho tenuta sempre con me, la sgrano tutti i giorni nel rosario di preghiere che rivolgo a Maria perché mi dia la forza di procedere nel mio cammino. Desidero che da questo momento l'abbia tu, sempre con te, certo che la mia mamma, dal Cielo, vede e approva. Come vede e approva la Madre di Cristo e nostra."
E Remo dette a Tarcisio la vecchia corona che terminava in un piccolo Crocefisso, lucido per il tempo e per le infinite volte che lo avevano carezzato le mani del seminarista, del sacerdote, del vescovo.
Tarcisio la prese, in silenzio, la mise al collo, baciò il Crocefisso, si inginocchiò.